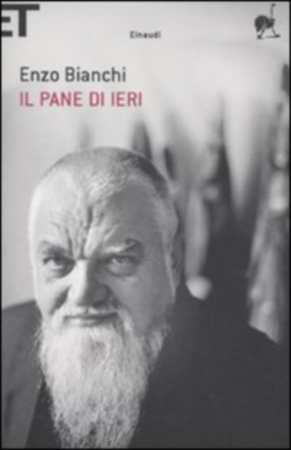 È particolarmente difficile cercare di affibbiare una delle convenzionali etichette della storia e della critica letteraria a “Il pane di ieri” di Enzo Bianchi. La categoria che più si avvicina, ma che sicuramente non riesce a inglobare nella sua totalità questo scritto, è il neorealismo.
È particolarmente difficile cercare di affibbiare una delle convenzionali etichette della storia e della critica letteraria a “Il pane di ieri” di Enzo Bianchi. La categoria che più si avvicina, ma che sicuramente non riesce a inglobare nella sua totalità questo scritto, è il neorealismo.
Certo, fatto in questi termini, il discorso apparirebbe semplicistico e persino tedioso: leggere “Il pane di ieri” equivarrebbe a riportare alla luce un fossile letterario (quello neorealistico appunto) sicuramente poco gradito alla generazione che preferisce l’e-book al contatto magico e affascinante con la carta del libro stampato.
Tuttavia, seguendo l’insegnamento di Sciascia che, parlando della verità, descriveva la sua presenza «nel fondo di un pozzo» al di là degli illusori riflessi del sole o della luna siamo costretti ad un’analisi più approfondita che fa emergere il libro di Bianchi sotto una prospettiva certamente gradita anche ai seguaci della letteratura più commerciale.
“Il pane di ieri” si presenta come un tentativo di far risorgere dal tempo antichi modi di vivere e ancestrali tradizioni di un periodo (quello del secondo dopoguerra) e di un luogo (le incantate e produttive colline piemontesi) in cui «se non c’era la fame, per molti c’era […] ancora miseria e per tutti la vita era dura».
Bianchi affronta dunque un’impresa narrativa sicuramente non semplice schivando con maestria due imponenti scogli (la nostalgia, inevitabile nella vecchiaia, e le tentazioni idilliache) che avrebbero portato irrimediabilmente a compromettere il suo testo. Ciò non toglie che anche “Il pane di ieri” presenti delle crepe: la prima, e forse la meno individuabile, è la mancata descrizione del netto contrasto tra alcune abitudini del passato e le mode del presente (Bianchi non usa una scrittura contrastiva, ma lascia al lettore il compito di inferire l’attrito tra i tempi che furono e quelli che sono); la seconda è il campanilismo che dalla prima all’ultima pagina intride il testo in questione: Bianchi diventa quasi ossessivo nel ripetere costantemente la sua provenienza dalle terre delimitate dalle Langhe e dal Monferrato e ciò implica anche un metaforico restringimento del campo visivo che induce l’autore a ritenere determinati atteggiamenti monopolio dei contadini piemontesi mentre, ad un’analisi antropologica più accurata alla luce dei testi di Rasmussen, De Martino, Lombardi- Satriani, inevitabilmente emerge la comunanza di tali comportamenti tra tutti i ceti popolari dell’Italia pre e postbellica.
Nonostante questi limiti la lettura de “Il pane di ieri” si presenta scorrevole e istruttiva, in grado di mostrarci quel «mestiere di vivere» (la vita intesa come dovere) tanto caro al langarolo Pavese che oggi è stato scalzato dalla superficialità e dal caos mediatico- affaristico.
Del resto Bianchi, pur celandolo dietro le immagini del passato senza far riferimento diretto al presente, invita col suo racconto alla quiete interiore che, stranamente, nonostante la sua condizione monastica, non viene identificata con Dio, ma col fruire semplicemente dei frutti del proprio lavoro che tanto più risultano graditi quanto maggiore è stato il sacrificio per produrli.
Ecco allora che il pane e il vino non diventano semplici alimenti, ma il risultato di un’attesa e di una speranza e lo scopo di ancestrali capacità tecniche evolutesi nel tempo, ma che hanno custodito tuttavia un nucleo rimasto immutato e tramandato così di generazione in generazione (pensiamo un attimo al pane che gli assiri cuocevano in otri di terracotta, i greci sotto la cenere, gli ebrei su pietre arroventate e noi cuciniamo negli esteticamente orribili forni elettrici).
In questa chiave di lettura il pasto stesso diventa un rito da celebrare rigorosamente in comune poiché «se […] mangiare significa conservare e incrementare la vita, preparare da mangiare per un altro significa testimoniargli il nostro desiderio che egli viva e condividere la mensa testimonia la volontà di unire la propria vita a quella del commensale».
Dunque, in ultima analisi, il libro di Bianchi diventa necessario per il lettore che, attraverso le immagini sbiadite ma palpitanti del passato, vuole percorrere un viaggio interiore convinto, alla maniera di David Grossman, che «svelare a una persona qualcosa che non sa di se stesso è un grande dono d’amore. Il più grande».








